
Lo sa bene mia madre, che quando avevo cinque anni si è fatta cinque bagni sulla riviera veneta per venirmi a prendere dopo che mi ero allontanato per cercare Pokémon, e che quando avevo diciannove anni mi ha ripescato dalla voragine del divano in cui mi ero affossato, perché ancora inconsciamente non avevo accettato che il mio amore, nella vita, dovesse essere per forza un lui; queste due volte, più un numero non quantificabile di volte nel mezzo.
Allo stesso modo, mi è capitato molte volte di ritrovarmi, di scorgere una diversa versione di me stesso in luoghi in cui non avrei mai pensato, durante il mio percorso di crescita da fruitore multimediale abbastanza onnivoro, tra le pieghe di narrazioni formalmente eterogenee: è capitato tra le orecchie di libri dai caratteri sbiaditi, tra i fotogrammi di pellicole cinematografiche più o meno impegnate, tra le note e i testi di numerosi brani musicali, spesso intonati da voci femminili perché sia mai che mi distacco troppo dal cliché del classico omosessuale fan di Madonna.
Mi è accaduto spesso anche tra i colori e i suoni del mio primo grande amore, l’animazione, poi tra le linee cinetiche, i chiaroscuri, i silenzi e le onomatopee del secondo, il fumetto; e anni dopo, mi è successo, pad alla mano, con una delle mie vecchie e più ardenti fiamme, l’ultimo della triade, sua maestà il videogioco, che avevo colpevolmente abbandonato nel tempo per non so quale motivo e che ho riscoperto solo nell’ultimo anno, complice l’arrivo, fortuito quanto sudato, di una ps5 tra le mie quattro mura domestiche.
Sulle ragioni di questa mia trascuratezza del medium, durata più di qualche anno, mi sento di voler soprassedere: ciò che ha avuto valore per questa storia, invece, è stata la possibilità di vedermi in quei personaggi con i quali avevo interagito giocando. Niente di nuovo per gli avvezzi ai rotocalchi della Critica Videoludica™️, ne sono conscio; ad ogni modo, per me è stato molto importante lo sviluppo di quelle connessioni, il sentirmi un po’ Ellie, un po’ Zagreus, un po’ Tyler Ronan, o il prendermi una cotta per il manzo di turno (Chris Redfield, Nathan Drake o Joel, perché ho un evidente problema con il daddy disfunzionale di turno), e anche il potermi immaginare bionda e figa sotto il mantello rosso del viaggiatore di Journey.
Ne per me, ne per tuttə quellə con cui ho condiviso quel viaggio tra le sabbie dorate fatte di pixel di thatgamecompany.
Niente che non sia già stato detto, di nuovo, eppure fa sorridere pensare che sono stati fatti passi da gigante rispetto a quando giocavo da bambino a Super Mario Advance su GBA e neanche potevo immaginare che la prima versione di Birdo, in Super Mario Bros 2 per NES, fosse un personaggio transgender, ovviamente relegato al ruolo di villain perché, si sa, correva l’anno 1998 e il ragionamento sull’identità di genere si era forse fermato a qualche salotto dei più illuminati.
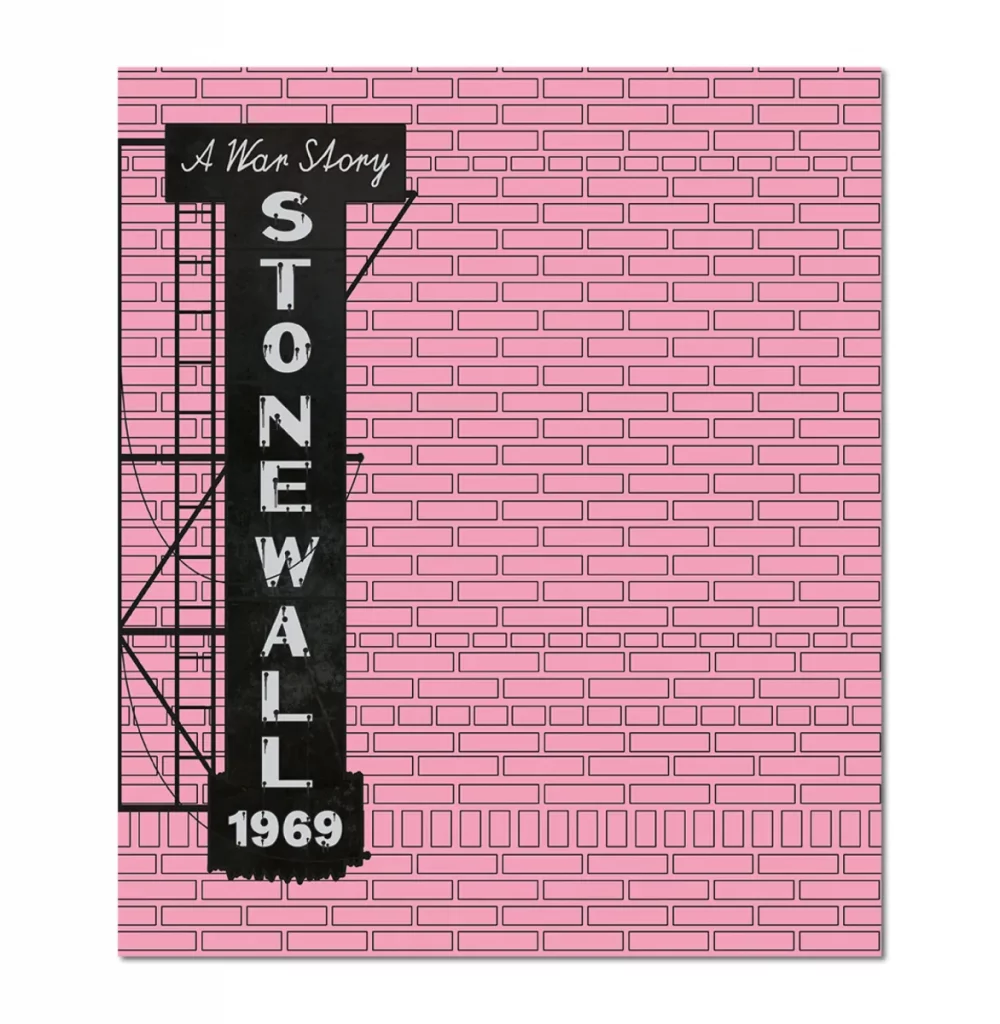
Una piccola ma doverosa precisazione, a questo punto, è d’obbligo prima di continuare. Ho iniziato il discorso parlando della mia personale e soggettivissima esperienza, ma io non sono nessuno. Nessuno al di fuori di me stesso, sia chiaro: far parte della community LGBTQIA+, dopotutto, implica quantomeno che si è compiuto quel piccolo passo che porta all’autodeterminazione, all’affermazione della propria persona – questo discorso, a mio parere, è valido anche nel momento in cui decidiamo di non definirci, ma questi sono i miei personalissimi due centesimi sull’argomento. Sesso biologico, identità di genere e orientamento sessuale altro non sono che strumenti per aiutarci a capire chi siamo, a raccontarci e spiegarlo all3 altr3. Ma a parte questo, io davvero non sono nessuno, e non vi serve sapere altro. Perché se quel che sono è semplicemente una maschera, ciò che conta è se dietro quella maschera c’è un’idea, se questa è valida e ha senso di esistere e se questa è (e lo è, concedetemelo) a prova di proiettile. Una verità tanto melensa quanto incrollabile:
Non è tanto ciò che sono, quanto quello che faccio, che mi qualifica.
Così, dopo le citazioni a due grandi pellicole del cinema contemporaneo (“V per Vendetta” e “Batman Begins”), di sicuro ci siamo tolti dai coglioni piedi in un colpo solo tutti i vari sommelier dei mass media che credono che la “vera arte” esuli per forza dai prodotti mainstream e anche tutti gli elitisti che intonano all’unisono il grido di battaglia “eh però i fumetti le graphic novel sono meglio” (con i quali, per inciso, non mi sento tuttavia di dissentire). Non male, per essere soltanto a metà.
Riprendiamo un attimo le redini del discorso. Se è vero che non è fondamentale chi sono, in questa sede è sicuramente importante la comunità nella quale mi identifico. E qui, purtroppo, urge ammorbarvi nuovamente con una ulteriore divagazione. Premetto, e prometto, che cercherò di mantenere il più possibile il filo.
Lo è se e solo se vi si partecipa con uno spirito individualista, se la propria unica aspirazione è gridare “io ci sono per la causa”, ancora meglio se lo si fa da dietro uno schermo come un leone da tastiera basic (e in un certo senso, potreste pensare che io mi stia limitando a questo).
Non lo è, invece, se si ragiona con spirito critico sull’esistenza frammentaria della stessa comunità, se si compie quel salto logico che ci permette di vedere che non è tutto quanto bianco e nero e che ci sono determinate contraddizioni intrinseche al movimento cui scegliamo di appartenere. Perché le contraddizioni ci sono sempre: scegliere di non vederle non può essere considerato strumento valido ai fini della discussione. Esclusa la possibilità di qualsiasi scetticismo epistemologico sull’argomento, possiamo dunque togliere il velo e scoprire insieme l’elefante nella stanza:

Un’ovvia argomentazione a riguardo deriva certamente dalla presenza, all’interno del grande insieme, di numerose sottocategorie che altro non sono che le lettere della sigla. Gay, lesbiche, bisessuali, persone trans, queer, intersessuali e asessuali. Queste sono solo le prime categorie di un elenco che continua ulteriormente e, ci tengo a specificare, sono le “prime” solo nel senso dell’ordine in cui compaiono nella sigla. Sigla che, peraltro, ha numerose variazioni nei vari paesi del mondo (LGBTQIA+ è quella attualmente in voga in Italia) e che continua a cambiare in tutte le sue manifestazioni, aggiungendo sempre più lettere dell’alfabeto. Una gara a chi ce l’ha più lungo, l’acronimo. Certo, questo è probabilmente un papabile argomento principe dei detrattori della community, e come tale va citato anche solo per depotenziarne l’utilizzo; personalmente, non vedo l’ora che aggiungano XYZ alla lista, così potremo vantarci di sembrare i fighissimi mostri di Seto Kaiba. Del resto, che per tanti siamo considerati dei mostri già lo sapevamo, e se nutrite qualche dubbio a riguardo, l’enciclopedia vi fornirà delucidazioni in merito alle differenti accezioni della parola “mostro”.
Per sottrarre potere a questa visione frammentaria e non unitaria della categoria in questione, vengono utilizzati i cosiddetti “termini ombrello” per racchiudere i significati delle varie pluralità, definite in base ai concetti di gender identity, sexual orientation e gender role. Per questo motivo, si fa riferimento alla community LGBTQIA+ anche come “comunità queer”, sposando una scelta storicamente affermatasi in controtendenza per sottolineare l’appartenenza ad un unico insieme più grande, piuttosto che alla sua divisione in categorie. Nel compiere questa scelta, però, teniamo presente che ogni singola componente è molto più di una semplice etichetta: ogni lettera dell’acronimo, del resto, è il frutto di un lungo processo di definizione delle singole minoranze, dell’affermazione storica di queste nuove identità e della loro inclusione in un movimento minoritario d’insieme, ma è anche l’unione di componenti estremamente eterogenee, fatte di “persone ™️”; dell’importanza dell’unicità individuale ne ha già parlato Darwin nel 1859, quindi direi che possiamo darlo per assodato, ma mi riservo l’utilizzo delle virgolette e del marchio registrato come un non troppo velato j’accuse alle recenti derive politiche, che non sembrerebbero considerarci come tali.
Che casino, vero? Due visioni, non necessariamente inconciliabili, sulla stessa questione, costrette a stare nella stessa stanza, una cameretta già stretta anche solo per una di esse, come due fratelli che da bambini condividevano gli stessi spazi. Una stanza per la minorità, per quel “tutt3” che è trino come quel Dio che ogni tanto ci viene da chiamare in causa, sappiamo bene con che termini – nel dubbio, controllate l’URL e vi sarà tutto più chiaro. Perché io sono me stesso, ma non sono nessuno per parlare di certi temi, a meno che non decida di parlarne per tutti. Uno, nessuno, centomila e anche di più: una sorta di rilettura del pensiero pirandelliano, in chiave più queer, se non altro. Che visti i tempi non stona, ecco.
Ed ecco che una domanda pare a questo punto fare capolino spontanea, chiedendo a gran voce risposta..perché vi sto dicendo questo?
Racconto di questa scissione perché al di fuori della community queer sembra ancora radicata l’idea che siamo un gruppo coeso, e questa narrazione, per chi non bazzica come gli allies i temi cari alle nostre minoranze, sembra ancora essere quella dominante, egemonica: la visione del pride, dell’orgoglio gay e anzi queer in generale, ridotta, per chi viene da fuori, ad un giorno o un mese dell’anno in cui si crede che siamo tuttə parte dello stesso esercito, prontə a lottare per i nostri diritti. La verità è (stereotipo gay incoming) che ci piace un casino tirarci i capelli tra di noi, e che su una miriade di temi non la vediamo tuttə allo stesso modo.
Grazie al cazzo, mi vien da dire.

E uscire dalla campana di vetro del pensiero queer unificato, per abbracciare l’idea che siamo pluralità in mezzo all’unione, per me è stato come quando Charlie si toglie il casco per respirare l’aria di casa nella Golf Club: Wasteland: sa che farà male, che questa lo ucciderà, eppure decide di soddisfare quel bisogno, non solo fisiologico ma anche emotivo, di prendere una boccata di aria fresca, di aria vera. E proprio nel momento in cui decide di tornare a respirare, si apre alla possibilità del diverso, cambiando il corso forse non della storia, ma certamente della propria esistenza. IO SONO CHARLIE, per dirla come i francesi; ironico pensare come anche questa volta, questa frase assuma una connotazione politica.
Questo articolo è frutto dell'iniziativa Crowdsourcing sovversivo di Gameromancer. Che è 'sta cosa?